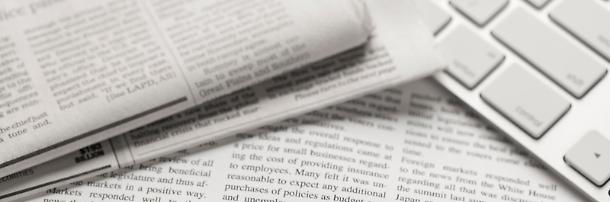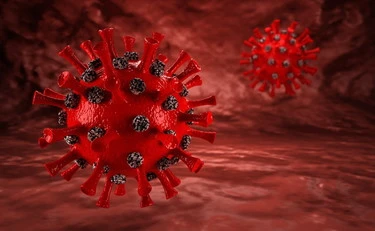Nel garantire guarigione definitiva o remissioni prolungate, i farmaci antitumorali provocano inevitabilmente effetti collaterali, non ultimi al cuore e al sistema circolatorio. “Il problema della cardiotossicità dei trattamenti antitumorali non va enfatizzato in senso allarmistico, ma nemmeno sottovalutato”, spiega il Professor Giorgio Minotti, Responsabile dell’Unità Operativa di Farmacologia dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. “Qualunque sia la dimensione del rischio cardiovascolare e la preoccupazione per eventi cardiaci – aggiunge – la priorità rimane quella di somministrare al paziente la terapia antitumorale più efficace e adeguata alle sue condizioni di salute”. Condizioni che variano con l’età. Da qui l’esigenza – rimarcata da tutti gli esperti – di definire strategie adeguate all’età del paziente, siano esse di prevenzione, monitoraggio, o eventuale correzione farmacologica del danno cardiocircolatorio. Nei bambini, nei quali le complicanze cardiovascolari possono manifestarsi anche dieci o venti anni dopo la terapia antineoplastica, si è rivelata strategica l’adesione a programmi di sorveglianza coordinati da specialisti capaci di cogliere e interpretare adeguatamente il rapporto causa-effetto tra terapia somministrata in età infantile-adolescenziale ed eventi cardiovascolari manifestatisi in età matura. Paradigmatico è il successo del Childhood Cancer Survivors Study negli Stati Uniti e di iniziative simili nel Regno Unito e in Olanda. Negli adulti – spiega il Professor Minotti – sono necessarie misure di buon senso, come una correzione adeguata di eventuali altre patologie concomitanti, un adeguato recupero dell’attività fisica e controlli cardiologici periodici, non ossessivi ma ben distribuiti nel tempo. Negli anziani, occorre tenere presente il quadro fisiopatologico della fragilità, “che non significa rinunciare a priori al farmaco anti-tumorale, quanto piuttosto valutare attentamente la dimensione del rischio, modellare la somministrazione dei farmaci anche più cardiotossici, come le antracicline, alla effettiva risposta del paziente e disegnare un programma di assiduo controllo medico". Il Congresso ha evidenziato come anche i cosiddetti farmaci ‘intelligenti' o ‘a bersaglio', sviluppati per essere attivi sul tumore ma non sui tessuti sani, non eliminino il rischio di complicanze cardiovascolari. Un certo livello di rischio rimane dietro l'angolo e richiede molta attenzione nella identificazione di anomalie precoci, spesso asintomatiche, che con il tempo maturano verso eventi più significativi. “È necessario che chi si prende cura dei pazienti oncologici, auspicabilmente attraverso unità integrate di oncologia e cardiologia, li controlli con prudenza e per molto tempo”, prosegue Minotti. D’accordo con questa conclusione è il Prof. Steven E. Lipshultz, docente alla Wayne State University e coordinatore di una delle maggiori unità mondiali di cardio-oncologia presso l’Henry Ford Children Hospital di Detroit. “Identificare i fattori di suscettibilità individuale alla cardiotossicità – sottolinea Lipshultz – è fondamentale, specie nei bambini e negli adolescenti sopravvissuti a un tumore. Non tutti, infatti, reagiscono in ugual modo all’utilizzo di farmaci antitumorali, il che sembra indicare con sempre maggiore evidenza la possibilità di una predisposizione genetica. Il nostro obiettivo sarà massimizzare l’efficacia dei farmaci antitumorali riducendone per quanto possibile gli effetti tossici”. Sulla stessa linea, tra gli altri, la Prof.ssa Flora E. van Leeuwen, docente al Netherlands Cancer Institute di Amsterdam. Parlando del trattamento radiante del linfoma di Hodgkin ha spiegato che “la tossicità cardiovascolare ne rappresenta un importante effetto collaterale, ma non è ancora chiara la soglia di radiazioni oltre la quale si genera. È tuttavia innegabile che le moderne tecniche radioterapiche consentano una migliore protezione della funzionalità cardiaca. Sarà importante concentrarsi sulla loro ulteriore ottimizzazione”. I partecipanti riuniti al Convegno hanno sottolineato anche gli interrogativi ancora aperti che la cardio-oncolgia deve affrontare. “Nonostante i progressi nelle conoscenze, non esiste ancora una definizione condivisa di cardiotossicità, sia dal punto di vista fisopatologico che della indicazione ad una terapia farmacologica o ad una rivalutazione del piano terapeutico oncologico. Tutto ciò pone naturali problemi nella valutazione del rischio-beneficio. In questa direzione, i ricercatori stanno lavorando all’individuazione di markers che possano aiutare a identificare i pazienti con rischio cardiovascolare più accentuato. Marcatori che possono essere genetici, come spiegato dalla Prof.ssa Leontien Kremer, docente presso lo Emma Children's' Hospital di Amsterdam, oppure biochimici e dosabili nel sangue, come chiarito dalla Dr.ssa Daniela Cardinale, dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano. “Abbiamo acquisito nozioni grazie alle quali – conferma Minotti – in un futuro non troppo lontano potremo realizzare screening che aiutino a identificare i pazienti a maggior rischio di danni cardiovascolari”. Il messaggio più forte lasciato dal Convegno è che “la cardio-oncologia è una disciplina sufficientemente complessa da meritare ambiti di competenza forse più ampi di quelli cardiologico e oncologico. Le nozioni fin qui ottenute sono il risultato del lavoro svolto anche da genetisti, epidemiologi, ricercatori di laboratorio. Vi è quindi bisogno di una maggiore multidisciplinarietà e da questa collaborazione potrebbe giungere la soluzione per diagnosi più precoci, farmaci meno tossici, oppure cardioprotettivi, nonché per valutazioni più precise dei pazienti a rischio”, conclude Minotti. (P. RUS.)