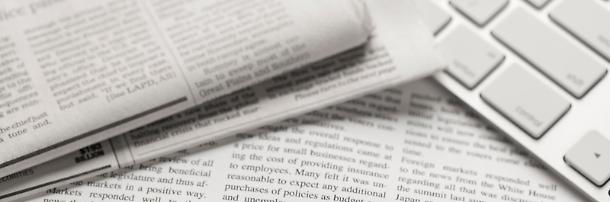Da oggi è in libreria «L’eresia liberale», il libro di Alessandro Sallusti (Rizzoli). Il direttore de «Il Giornale» parte da episodi della sua vita personale e professionale e mostra il punto di vista eretico di un liberal-conservatore abituato a sentirsi minoranza, spesso irrisa, nei salotti buoni della cultura dominante. Contro le pericolose utopie buoniste, il conservatorismo rappresenta la voce del buonsenso in accordo con la realtà. Per concessione dell’autore e dell’editore, di seguito pubblichiamo un estratto del libro. Mettiamo in fila quattro concetti chiave che ci accompagneranno nel viaggio di questo libro. Il primo riguarda la legittimità del nostro «punto di vista», un concetto che nelle parole di Winston Churchill è così spiegato: «Ciascuno descrive un’azione dal proprio punto di vista.
In effetti è da lì che guardiamo generalmente le cose, umane o divine che siano. Perché dovrei essere io un’eccezione?». Il secondo tocca la libertà, intesa come quella cosa descritta dal filosofo francese Gustave Thibon, detto «il filosofo contadino» per aver scelto di vivere in campagna anziché nei salotti parigini: «L’uomo non è libero nella misura in cui non dipende da nulla o da nessuno: è libero nell’esatta misura in cui dipende da ciò che ama. Ed è prigioniero nell’esatta misura in cui dipende da ciò che non può amare». Il terzo concetto attiene al modo di comunicare e lo si ritrova nelle parole di Charles De Gaulle, il generale padre della moderna Francia: «Le cose principali che sono state dette all’umanità sono sempre state delle cose semplici».
Il quarto spiega che cosa sia una minoranza, missione che si era data Ayn Rand, filosofa di origine russa che nel Novecento ha fondato la corrente dell’oggettivismo, ponendo da destra la questione dei diritti individuali in anni in cui il tema non era all’ordine del giorno: «La più piccola minoranza al mondo» sostenne «è il singolo individuo. Chiunque neghi il diritto del singolo individuo a cercare il proprio bene senza arrecare danno a nessuno, la propria felicità grazie alle proprie abilità, non può essere difensore di nessuna minoranza». Se qualcuno non difende i miei diritti non può arrogarsi il diritto di difendere quelli di chiunque altro.
Che cosa unisce Churchill, Thibon, De Gaulle e Ayn Rand? Che sono stati quattro grandi interpreti del conservatorismo liberale - Thibon anche di quello cattolico - del secolo scorso. E che evidentemente avevano intuito a ragione il rischio che il conservatorismo stava correndo, cioè che il loro pensiero non avrebbe potuto avere pari dignità rispetto ad altri; che un conservatore liberale non avesse diritto di «amare il suo punto di vista», pena l’essere scomunicato in quanto eretico che si contrappone al pensiero dell’unica verità possibile, quella rivelata e proposta dalla sinistra, che affonda le radici nella piaga del comunismo novecentesco rivisitato in salsa globalista e con il volto gentile del solidarismo universale.
Eretici, quindi indegni di partecipare al dibattito democratico al punto che a papa Benedetto XVI, il conservatore Joseph Ratzinger, nel 2008 fu impedito di parlare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università La Sapienza di Roma; eretici come oggi i conservatori in Italia, ritenuti non degni di governare il Paese tanto da essere messi al rogo, come accade spesso con i manichini e le effigi cartonate dei loro leader durante le manifestazioni di piazza.
La parola «eresia» deriva attraverso il latino dal greco háiresis che significa «scelta», non certo «scelta sbagliata» come ci si vuole fare credere, e a chi ha qualche dimestichezza con la storia non sfugge che molti dei personaggi bollati come eretici hanno in realtà, essendo nella ragione, cambiato in meglio la storia del mondo. Come sia stato possibile permettere alle sinistre di farci precipitare in un neo-medioevo, cioè in un’epoca in cui è prassi demonizzare il pensiero diverso dal loro, non è spiegabile solo con la parentesi del nazifascismo e il timore, del tutto infondato, di un suo possibile ritorno: quella tragedia non fu l’unica del Novecento.
Come scriveva infatti lo storico François Furet nel saggio Il passato di un’illusione, c’è una dissimmetria nel ricordare e giudicare i misteri del male delle due folli idee politiche del XX secolo, cioè tra quella di Hitler «che in nome della purezza della razza ariana ha fatto sterminare milioni di ebrei» e quella di Stalin «che in nome della lotta contro la borghesia ha sterminato milioni di persone». Ne deriva che mentre il giudizio sulla ferocia del nazismo è tombale e pressoché unanime, quello sulla nascita ed evoluzione del comunismo è invece ancora oggi tema di discussioni, distinguo e ammiccamenti. E neppure sta in piedi sostenere che il pensiero liberal-conservatore sia stato inquinato da abusivi compagni di viaggio - gli estremismi della destra con il braccio alzato e gli eccessi dei populisti - con i quali non solo non ha nulla da spartire o scusarsi ma che rappresentano una minoranza tale da non poter incidere in alcun modo né sulla rotta né sulla meta.
Può invece essere che la forza del pensiero liberale – la libertà collettiva e individuale come valore assoluto – si sia rivelata nel tempo la sua debolezza. Già, perché la libertà è un’arma a doppio taglio, come la pistola che in mano a un carabiniere difende le libertà ma se nelle mani di un delinquente le libertà le opprime. Può essere cioè che i nemici del liberalismo, quindi dell’Occidente, in Italia come nel mondo, stiano usando le nostre libertà – di espressione, di movimento, d’impresa e di commercio – per conquistare spazi d’azione e di potere che con i loro mezzi e principi non potrebbero mai ottenere, sul modello della Cina che ha mutuato alcune regole e libertà del capitalismo senza rinunciare alla sua anima comunista e alla sua ambizione imperialista.
Insomma, temo che senza accorgercene siamo caduti in una trappola e se solo si prova a reagire ci si trova assediati e delegittimati. Questa che segue è la storia di una presunta eresia – essere di destra, ma è sufficiente non essere omologati alla sinistra – figlia di un grande imbroglio con cui da cinquant’anni mi ritrovo quotidianamente a fare i conti, nella professione e nella vita privata: una storia di pregiudizi culturali e politici che non raramente si trasformano in giudizi carichi di odio e disprezzo fino alle minacce, tanto che per anni ho dovuto vivere sotto scorta. Ma mi è bastato pescare nella memoria fatti e vicende personali per smascherare le menzogne e documentare che le cose sono andate, e vanno, in maniera diversa.