Si è aperta alle Gallerie dell’Accademia di Venezia, in una rinnovata edizione, in continuità con la recente esposizione romana, la prima grande mostra antologica del pittore seicentesco Carlo Saraceni, fortemente voluta dalla Soprintendente al Polo Museale di Venezia, Giovanna Damiani, per far conoscere un artista fino ad oggi quasi ignorato nella sua città d’origine. Ideata da Rossella Vodret e curata da Maria Giulia Aurigemma, è stata allestita nelle sale delle Gallerie dell’Accademia secondo percorsi e scelte espositive curate da Roberta Battaglia, al fine di sottolineare in particolare i legami del pittore con Venezia, dove nacque nel 1579 e morì nel 1620. Si tratta dell’unico artista veneziano del suo tempo che, voltate con decisione le spalle alla cultura artistica tardo-manieristica veneziana e presa la strada di Roma, si accosta nei primi del Seicento alla visione artistica profondamente rinnovata in senso naturalistico di Caravaggio, assimilandola in modo graduale e del tutto originale. Il Saraceni, fu uno dei più precoci e importanti interpreti di Caravaggio e contribuì alla diffusione del linguaggio caravaggesco offrendone sempre un’interpretazione molto originale, caratterizzata dal vivido cromatismo intriso di luce della grande tradizione cinquecentesca veneta. Artista di successo colto e raffinato, sviluppò la sua arte principalmente a Roma dove giunse a circa vent’anni e dove era noto come il “Veneziano”. Rientrò nella città lagunare, chiamato dalla Serenissima per compiere un telero per Palazzo Ducale, ma morì solo dopo pochi mesi. La mostra comprende una sessantina di opere, tra cui non mancano le principali commissionate al pittore da alcune tra le più influenti famiglie romane, come il Riposo dalla Fuga in Egitto dell’Eremo dei camaldolesi, eseguito per la famiglia Aldobrandini che aveva portato al soglio pontificio (dal 1592 al1605) un suo esponente, Clemente VIII, e i dipinti eseguiti per alcune delle più importanti congregazioni ecclesiastiche straniere, come quella iberica di Sant’Adriano in Vaccino e quella tedesca di Santa Maria dell’Anima per la quale dipinse due autentici capolavori presenti in mostra. L’esposizione veneziana dà modo di seguire l’intero percorso dell’artista, secondo un ordine principalmente cronologico. Prende avvio dalla produzione di piccoli raffinati dipinti su rame, dove la novità maggiore sta nella predominanza data al paesaggio rispetto al racconto mitologico e biblico, frutto della profonda meditazione sui modelli dei pittori nordici specie di Adam Elsheimer. Nella serie mitologica del Museo di Capodimonte si aprono vaste lontananze paesistiche di largo respiro, qui la pittura restituisce al meglio la percezione sensibile dal vero, con particolare attenzione ai fenomeni della luce e dell’ombra e alle gradazioni tonali con cui sono definite le rocce, le masse arboree, i riflessi sull’acqua. Il Transito della Vergine, dipinto per la chiesa di Santa Maria della Scala in sostituzione della celebre Morte della Vergine di Caravaggio, rifiutata perché giudicata priva di “decoro”, segna probabilmente il primo punto di contatto con il linguaggio caravaggesco. La prima testimonianza documentaria del rapporto diretto tra Saraceni e Caravaggio, risale al novembre del 1606, quando nelle aule di un tribunale Carlo Saraceni e Orazio Borgianni, accusati di essere i mandanti dell’attentato a Giuseppe Baglione, vengono detti “aderenti al Caravaggio”. Le repliche tratte da questa composizione, esposte in mostra, aprono sulle modalità di lavoro del pittore che attraverso di esse diffonde e promuove, quasi sistematicamente, le sue invenzioni e il suo stile sul mercato collezionistico. Il percorso prosegue, tra fine primo e inizio secondo decennio del '600, con alcune pale di dimensioni più ridotte, eseguite per membri di famiglia aristocratiche di preferenze progressiste, da destinare alla devozione privata oppure a piccole cappelle di cui avevano la titolarità come la Madonna col bambino e Sant’Anna della Galleria Barberini, dove il gusto pittorico in senso caravaggesco si irrobustisce ma dove le sollecitazioni del Merisi sono epurate della loro intrinseca drammaticità, per essere tradotte con un senso di dolce intimità e pacatezza. E’ questo anche il momento in cui l’artista sviluppa la tematica di santi isolati, irrobustiti da viraggi chiaroscurali più intensi, campiti su fondali paesistici colti in particolari momenti del giorno così da temporalizzare il racconto e contribuire a trasferirlo nel presente potenziale dello spettatore dandogli anche una coloritura sentimentale, così si veda in mostra lo splendido San Rocco della Galleria Doria Pamphilj, dove il pittore mette in scena il fatto evangelico con un tono dolcemente sentimentale. Il percorso si conclude nella sala che riunisce le grandi pale chiesastiche del secondo decennio dove Saraceni, nell’affrontare le grandi raffigurazioni per gli altari, va progressivamente semplificando l’impaginazione data alle scene, riducendo il numero dei personaggi disposti intorno ai protagonisti, sottolineando i gesti con lame di luce che sottraggono i corpi alle ombre avvolgenti e profonde. Straordinarie le due pale per la chiesa della nazione tedesca, Santa Maria dell’Anima, saldate nel corso del 1618: immagini di eccezionale potenza e tensione drammatica, accentuata dai contrasti chiaroscurali e dagli accesi cromatismi, una sorta di testamento spirituale lasciato a Roma prima del rientro a Venezia. Una sezione della mostra è dedicata a illustrare il legame di Saraceni con alcuni giovani artisti veronesi, scesi a Roma attorno alla metà del secondo decennio del Seicento, che collaborarono con il pittore in alcune imprese decorative (cappella Ferrari in Santa Maria in Aquiro e Sala Regia al Quirinale). Tra loro, Marcantonio Bassetti con il Paradiso, risalente agli anni romani, ispirato all’analoga composizione giovanile di Saraceni ma tradotta con un fare pittorico molto più corsivo, e il Sant’Antonio che legge, eseguito al tempo del rientro a Verona (intorno al 1620-1621), suggestionato dall’Estasi di San Francesco di Saraceni; Alessandro Turchi detto l’Orbetto, presente con la Resurrezione di Lazzaro, acquistata da Scipione Borghese nel 1617, massima espressione dell’impatto del pittore con la cultura caravaggesca romana, e la Liberazione di San Pietro, della metà degli anni venti, dove i ricordi del naturalismo caravaggesco sono temperati da influenze del classicismo emiliano. Di Antonio Giarola, abitante dal 1617 al 1619 nella casa romana di Saraceni e pure menzionato nel testamento di quest’ultimo, redatto a Venezia nel 1620, come “Antonio Girola Veronese che mi serve”, di cui si espone il Miracolo della mula. Infine è presente anche Pietro Bernardi con la pala Sacra Famiglia con San Gioacchino e Santa Elisabetta, che testimonia la precoce apertura della cultura veronese alla poetica caravaggesca intorno alla metà del secondo decennio. Sono da segnalare alcune opere che arricchiscono la mostra veneziana come il disegno raffigurante Andromeda del Cavalier d’Arpino, conservato nel Gabinetto disegni e stampe delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, e posto a confronto con il piccolo dipinto giovanile di Saraceni di analogo soggetto, di chiara matrice arpinesca; lo splendido San Rocco della Galleria Doria Pamphilj accostato al San Girolamo di Jacopo Bassano, delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, per evidenziarne la componente veneta, e più specificatamente bassanesca, sempre indicata dalla critica; il dipinto della Maddalena penitente della Pinacoteca Civica di Vicenza, da accostare alle altre due versioni dello stesso soggetto, già presenti nella mostra romana. L’artista rientrò in laguna chiamato dalla Serenissima per eseguire un telero con Il Doge Dandolo incita le crociate per la Sala del Maggior Consiglio in Palazzo Ducale, destinato a sostituire un dipinto tintorettesco di soggetto analogo che si era danneggiato; il telero fu ideato e forse impostato dal pittore veneziano, ma venne compiuto e firmato, dopo la sua morte, dal francese Jean Le Clerc, suo allievo negli ultimi anni romani e trasferitosi con lui a Venezia. In mostra si trova esposto anche il testamento dell’artista, redatto in casa Contarini dove morì, conservato nell’Archivio di Stato di Venezia. E’ presente inoltre il volumetto commemorativo Dogliose lacrime della Biblioteca Marciana, scritto dal religioso Maurizio Moro in morte del pittore e dedicato a Giorgio Contarini, mecenate di Saraceni. Mostra di grande impegno che getta luce nuova su un grande artista veneziano che è stato capace di inseguire il Caravaggio, ma anche di travasare luci, ombre e colori in una percezione del vero sensibilmente rinnovata. di Carlo Franza
Carlo Saraceni in mostra alle Gallerie dell'Accademia di Venezia
di Giulio Bucchidomenica 20 aprile 2014
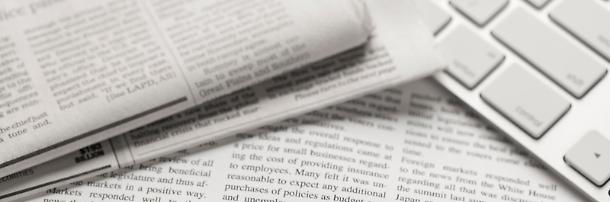
6' di lettura
