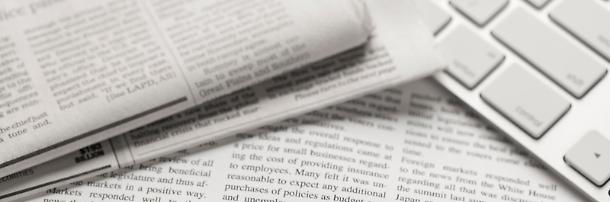Come per Montanelli, Gaber o Totò, scrivere, oggi, di Gianni Brera, dell’arcitaliano Gioanbrerafucarlo, tra le penne di più insolente bravura del 900, è un esercizio pericoloso: si rischia d’affondare nel banale. Sicchè, prendo a caso uno dei suoi fraseggi tratti da Storia di Gianni Brera 1919-1992 a cura di Franco Contorbia (Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori), «il giornalismo (l’infame giornalismo da corsa, ripeteva, ndr) e la povertà hanno strangolato lo scrittore che forse mi abitava, con altri inquilini. Scrivere d’invenzione è un piacere che rasenta il vizio, un pover’uomo che metta al mondo figli non se lo può permettere...». E realizzo di aver dinnanzi un monumento di alabastro che plasmò la lingua italiana partendo dallo sport, il più vaporoso dei mondi. La notizia è che, mentre lunedì verrà consegnato, al circolo culturale milanese I Navigli, il 15 ° Premio Gianni Brera, contestualmente si torna a parlare del giornalista-scrittore on un convegno, Il piacere ludico del prestipedatare a cura di Giuseppe Favi e Paolo Ortelli. E pure con una mostra, Rospi e lumaconi- Suggestioni dalla carte di Gianni Brera fino al 7 febbraio presso il Laboratorio Formentini per l’editoria, un percorso tra i documenti originali dall’Archivio Gianni Brera. E infine, per l’appunto, si recupera il Brera nel libro Storia di Gianni Brera 1919-1992, raccolta d’atti d’un convegno celebrato nel 2012, nell’anniversario della di lui morte. Di Brera, il pavese impossibile, sì è detto tutto. S’è parlato della sua capacità di addentrarsi nei labirinti della lingua italiana uscendone vincitore, un Teseo con in mano una bisaccia di neologismi e il filo d’Arianna delle onomaturgie entrate oramai nell’uso comune: argentinismo («gioco tipico di preziosità acrobatiche tipiche dei giocatori sudamericani»), prestipedatore («chi, essendo abile nel dribbling, fa giochi di prestigio con i piedi»), incornare («colpire di testa»), abatino «calciatore dal fisico non particolarmente atletico» ma valeva sia per Rivera che per Berruti), contropiede tratto dalla seconda parte della danza nel coro delle tragedie greche. Un modo come un altro, questo’ultimo, per sottolineare la propria superiorità classica nei confronti dei colleghi, i quali gli si appecoronavano accanto nel periodo d’oro e l’evitavano come un clochard degli stadi nei suoi periodi bui. S’è criticata - e sfruttata politicamente- la sua teoria sul «filtro delle razze», secondo cui i fantasisti del cuoio pallonato provenivano da un’etnia geografica sita tra il Ticino e l’Adige; e che se un centravanti sbagliava un gol era senz’altro di origini lucane. S’è discusso, poi, del caratteraccio di Brera, del suo esser « padano di riva e di golena, di boschi e di sabbioni. E mi sono scoperto figlio legittimo del Po» ; e del suo vagare giovanile da terzino nei campi milanisti e da paracadutista della Folgore in quelli elvetici per sfuggire alla Gestapo durante la guerra. Caratteraccio. Una volta, raccontava Gian Paolo Ormezzano, passata la frontiera con la Svizzera, un doganiere suo fan, riconsciutolo, gli gettò le braccia al collo: «Gianni, siamo forti!»; e lui, gelido: «Dietro i forti ci vanno a cagare i soldati». Gianni si giustificò, in seguito, dicendo che detestava i leccaculo, (ma non riesco a pensare allo squarcio nell’anima di quel doganiere). Per dire la riottosità dell’uomo. S’è detto di tutto di questo funambolo della parola, ispido, arrogante, che usava l’espressione con barba sfatta e pipa tra i denti come oggetto contundente contro la banalità; e che ha spinto un paio di generazioni -compresa la mia- a spellarsi le dita strattonando i «tiranti del bilancino Olivetti». Di Brera, in questa sede, invece, io preferisco ricordare la produzione letteraria. Tre romanzi: Il corpo della ragassa (1969), Naso bugiardo (77) noto anche come La ballata del pugile suonato, Il mio vescovo e le animalesse, scritti nei ritagli delle vacanze a Monterosso. Nei quali -meraviglia delle meraviglie- Brera diventava rigoroso come un monaco: evitava gli «intarsi alla Gadda», sosteneva il primato dei contenuti, scansionava il susseguirsi degli avvenimenti col ritmo del cinema. La sua contadina Tirisin (una tornita Lilli Carati nella versione cinetografica), il suo proessor Quario, il suo pugile Caludio Orsini, il suo vescovo Rovati sono ancora lì; a dimostrare che il grande scrittore non fu mai affatto soffocato dal più grande cronista sportivo di sempre... di Francesco Specchia
Gianni Brera, lo scrittore strangolato dal cronista perfetto
di Andrea Tempestinidomenica 31 gennaio 2016